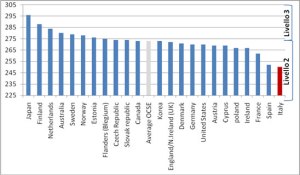Da INFOAUT.ORG
Il testo che segue è stato scritto da Niccolò, Mattia e Claudio arrestati il 9 dicembre scorso, insieme a Chiara. I tre compagni, per quanto isolati dal resto dei detenuti, hanno la possibilità di incontrarsi quotidianamente (Claudio e Niccolò condividono la stessa cella e si vedono con Mattia durante le ore d’aria e di socialità). Chiara è invece in un isolamento pressoché assoluto da ormai più di un mese, dato che nella sezione dove si trova non ci sono altre prigioniere in regime di Alta Sorveglianza. La censura cui è sottoposta tutta la loro corrispondenza provoca notevoli ritardi alla posta in entrata ed in uscita e così solo ora è possibile rendere pubblico questo testo scritto quasi un mese fa.
È di ieri la notizia che il Tribunale del Riesame ha rigettato ogni richiesta della difesa, compresa quella di derubricare i reati e le aggravanti di terrorismo. In aula i Pm Padalino e Rinaudo hanno ribadito come la condotta terroristica dei reati contestati ai compagni non sia da ravvisare tanto nelle modalità più o meno violente dell’azione contro il cantiere del maggio scorso, quanto nel contesto complessivo all’interno del quale questa si inserisce: l’opposizione alla realizzazione della Torino-Lione. A preoccupare realmente la procura torinese e l’intero Partito del Tav, è la lotta ormai ventennale contro il treno veloce, il tentativo di dare concretezza a quel No attorno al quale il movimento si è sviluppato.
Sono appena le 4 del pomeriggio e il sole sta calando dietro l’imponente termovalorizzatore metallico, mentre in lontananza si intravedono le prime montagne della valle e l’immaginazione completa i contorni accennati del Musiné. Siamo qui rinchiusi da 10 giorni ma il nostro pensiero viaggia ancora lontano…
Che la procura di Torino stesse preparando qualcosa di grosso lo sapevano pure i sassi. Lo si capiva dal crescendo di denunce contro il movimento, ma soprattutto da quell’intenso lavoro di propaganda con cui inquirenti, mass media e politici hanno cercato di traghettare la resistenza No tav all’ombra di quella parola magica che tutto permette: «terrorismo». Per mesi interi non hanno parlato d’altro, in un mantra ripetuto ossessivamente volto ad evocare una repressione feroce.
Infine hanno preso alcuni dei tanti episodi di lotta di questa estate su cui questo immaginario suggestivo potesse fare più presa e li hanno stravolti e piegati alla loro visione del mondo fatta di militari e paramilitari, gerarchie, controllo e violenza cieca.
Così hanno fatto per giustificare le perquisizioni di fine luglio, così fanno ora per argomentare i nostri arresti. Ma c’è un abisso tra ciò che vogliono vedere in noi e quello che realmente siamo.
Non ci interessa sapere chi in quella notte di maggio si è effettivamente avventurato tra i boschi della Clarea per sabotare il cantiere – probabilmente non interessa neanche agli stessi inquirenti -. Quello che vogliono è avere oggi qualcuno tra le mani per far pesare la minaccia di anni di galera sul movimento e sulla resistenza attiva, per arrivare tranquilli e indisturbati all’apertura del cantiere di Susa.
Vogliono che le persone restino a casa a guardare dal balcone il progetto che avanza.
Eppure queste persone hanno già gli strumenti per mettersi in mezzo: abbiamo imparato a bloccare quando tutti insieme si gridava «No pasaran» e a passare a colpi di mazza quando il cemento dei jersey ci sbarrava la strada; abbiamo imparato a guardare lontano quando l’orizzonte si riempiva di gas e a rialzare la testa quando tutto sembrava perduto.
Non sarà il terrore che seminano a piene mani a rovinare i raccolti futuri di questa lunga lotta.
Occorrerà continuare a costruire luoghi e momenti di confronto per scambiarsi idee e informazioni, per lanciare proposte e per essere pronti a tornare nelle strade e in mezzo ai boschi.
Si è fatta sera alle Vallette, ma a parte il buio non c’è una gran differenza col mattino, dato che il blindo della cella resta chiuso ventiquattr’ore su ventiquattro: alta sicurezza!
Rispetto ai Nuovi Giunti c’è molta più calma e pulizia, ma l’assenza di contatto umano ci debilita.
La bolgia dei blocchi B, C o F (a parte l’isolamento cui è costretta Chiara) sono un pullulare di storie ed esperienze di vita con cui impastarsi, in cui trovare complicità e solidarietà. Già nel mese scorso, Niccolò, già arrestato a fine ottobre per un altro procedimento, ha potuto constatare come l’eco della lotta contro il Tav sia giunto fin dentro le galere e per molti rappresenti il coraggio di chi ha smesso di subire le decisioni di uno stato opprimente.
Per noi, costretti all’isolamento in una sezione asettica, è di vitale importanza rifiutare la segregazione e la separazione tra detenuti: siamo tutti «comuni». Anche per questi motivi sarebbe bello se all’interno del movimento si sviluppasse un ragionamento e un percorso su e contro il carcere.
La maggior parte delle guardie delle Vallette vive qua, in dei grandi palazzoni all’interno delle mura, loro non si libereranno mai della galera. Per quanto in questa sezione ci trattino educatamente, non si tireranno indietro nel farci rapporto su ordine di un superiore quando decideremo di lottare per qualsivoglia motivo. Allora, coi ricordi che ci teniamo stretti, faremo rosicare questi «portachiavi» per la limitatezza dei loro orizzonti.
«Avete mai visto il mare farsi largo in mezzo ai boschi in un bel pomeriggio di luglio, e scagliarsi e andare contro le reti di un cantiere?»
«Avete mai sentito il calore umano di ogni età saldarsi spalla a spalla mentre gli scudi avanzano, l’asfalto dell’autostrada si fa liquido e le retrovie si riempiono di fumo?»
«Avete mani visto un serpente senza capo né coda o una pioggia di stelle nel cuore di una notte di mezza estate?»
Noi sì, e ancora non ci sazia.
La strada è lunga, ci saranno momenti esaltanti e batoste clamorose, si faranno passi avanti e si tornerà indietro, impareremo dai nostri errori.
Per ora guardiamo il nostro carcere negli occhi e non è facile, ma se «la Valsusa paura non ne ha», noi di certo non possiamo essere da meno.
Niccolò, Claudio, Mattia
Fonte infoaut.org
Immagine: radiocane.info